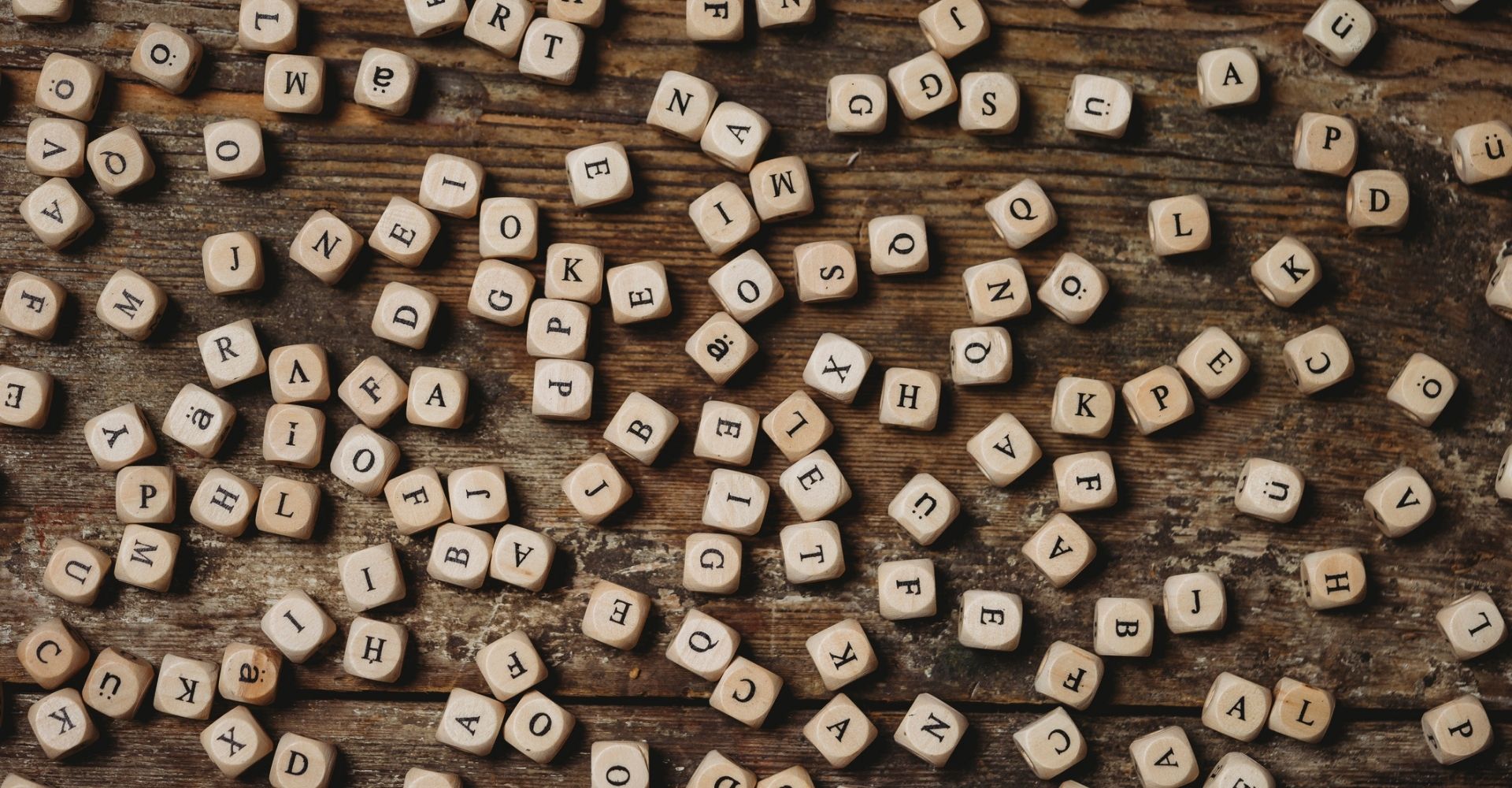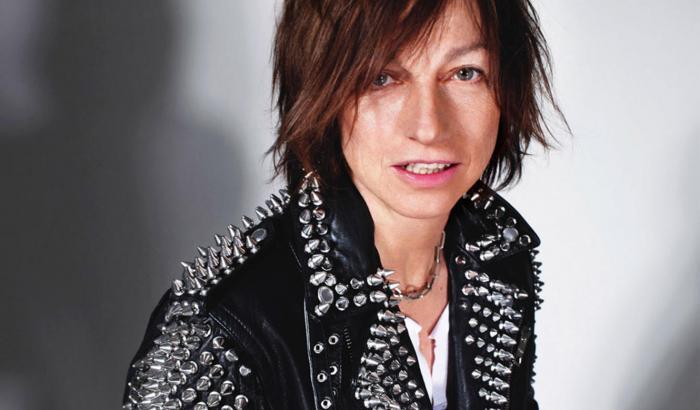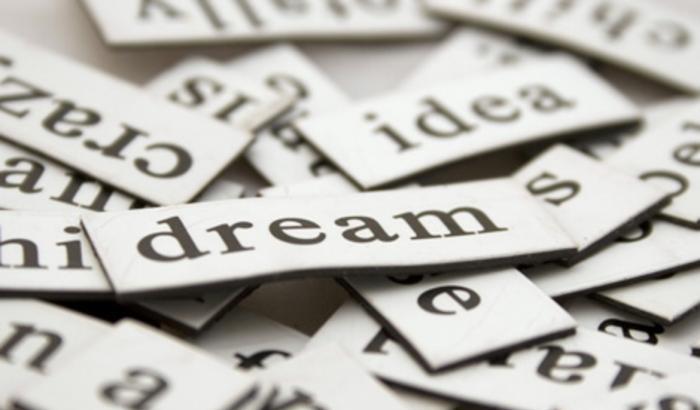A cento anni dalla nascita di Andrea Camilleri Excellera Intelligence ha svolto per Audible una ricerca sul rapporto tra gli italiani e i dialetti regionali. Per l’autore di Porto Empedocle il dialetto era “la lingua degli affetti”, una caratteristica particolare e distintiva della sua scrittura che mescolando lingua regionale siciliana e italiano ha dato vita a uno dei personaggi letterari e televisivi più apprezzati: Il Commissario Montalbano.
I risultati della ricerca, come scrive Ugo Barbàra per l’Agi, dimostrano che l’85% degli italiani conosce Camilleri e che il 71% ha avuto difficoltà nell’interpretazione del dialetto. Per nove italiani su dieci il dialetto è un caposaldo della cultura italiana e il 79% lo considera un ponte generazionale. Il 15% crede sia qualcosa di superato mentre quasi la metà degli intervistati pensa che venga parlato solo dalle generazioni meno recenti.
Secondo lo studio il dialetto resta molto utilizzato in contesti di intimità: il 55% degli intervistati lo utilizza in famiglia, il 49% con gli amici. Viene utilizzato anche per esprimere concetti difficili da restituire in Italiano o per fare battute divertenti. Il 34% lo utilizza per esprimere emozioni forti, avvalorando l’idea dello scrittore siciliano che individuava il dialetto come “la lingua del cuore, un fatto confidenziale, intimo, familiare”
Anche nell’utilizzo delle lingue territoriali esiste una differenza generazionale: i più giovani affermano di essere più preparati in inglese che nel dialetto (6,9 contro 5,9), ma all’aumentare dell’età il dato si ribalta. Non mancano le differenze geografiche dove vediamo una prevalenza della conoscenza dell’inglese nell’area Nord Ovest (5,8 contro 5,5), mentre a Nord Est, Centro, e soprattutto al Sud e nelle Isole il dialetto prevale sull’inglese (7 di media contro 5,5). I dialetti preferiti dagli italiani sono il romanesco (39%) e il napoletano (38%), seguiti dai dialetti toscani (31%), dal siciliano (24%) e dal romagnolo (22%).
Insieme a Camilleri sono ricordati per l’uso del dialetto anche Trilussa ed Eduardo de Filippo, che ha reso il napoletano una lingua da palcoscenico in tutto il mondo. Ancora, Carlo Porta con il milanese, Pier Paolo Pasolini con l’unione di italiano e friulano e Dario Fo, che rese il grammelot e i dialetti lombardi lingue del teatro popolare e politico. L’uso del dialetto è dunque necessario per restituire l’autenticità di un luogo e di una quotidianità, ma anche una musicalità caratteristica al racconto. Il dialetto, infatti, resta ancora apprezzato e gli intervistati sperano in un recupero del dialetto nella quotidianità (67% degli intervistati), mentre il 54% si dichiara favorevole al suo insegnamento negli istituti d’istruzione.
A oggi solo il 3-4% dichiara di fruirne regolarmente, mentre la lettura di testi dialettali riguarda il 19% e la visione di film o spettacoli in dialetto arriva al 33%. Due italiani su tre si dichiarano interessati ad ascoltare brani letterari nel dialetto della loro terra. Il 64% ritiene inoltre che gli audiolibri possano facilitare la comprensione della lingua locale e l’86% li vede come un’opportunità per valorizzare la cultura regionale. Il dialetto si afferma dunque come patrimonio culturale che invade la sfera dell’emotività, come un modo per descrivere il presente secondo un’identità condivisa. In sunto, le lingue che frammentano l’Italia in realtà la unificano sotto i suoni cantati e raccontati dalle generazioni precedenti.