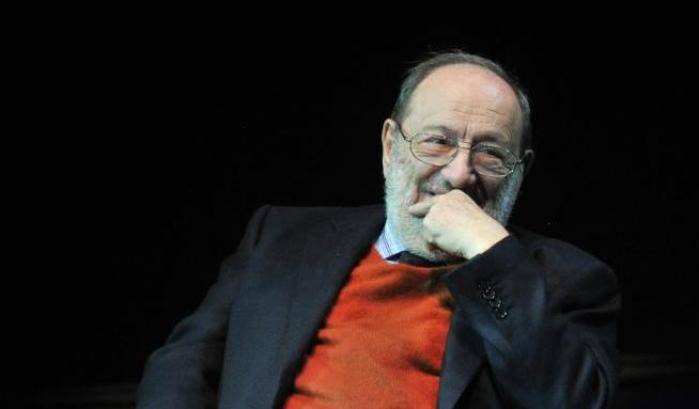Le recenti affermazioni di Roberto Vecchioni nel corso di un incontro in una scuola superiore, secondo cui “Solo il liceo classico dà senso alla vita” e “senza una formazione classica manca gran parte del senso dell’esistenza, lavori ma non sai perché”, hanno inevitabilmente suscitato un certo clamore mediatico. Il cantautore non è nuovo a dichiarazioni di questa natura, infatti più volte ha difeso lo studio delle materie classiche rimarcando come queste riescano ad aprire nuovi orizzonti culturali e fornire altre chiavi di letture della realtà a chi le studia. Partendo da un commento su tali parole ho chiesto al prof. Maurizio Bettini, Direttore del Centro “AMA” dell’Università di Siena, di riflettere su come il liceo classico si collochi nel contesto socioculturale odierno e su quali siano le sue sfide.
In prima battuta Chiedo a Bettini un’opinione sulle recenti affermazioni di Vecchioni, che in molti hanno etichettato come frutto di una ‘spocchia radical chic’. Questo il suo giudizio: “Sicuramente si stratta di affermazioni abbastanza decise. Personalmente farei una distinzione tra l’analisi del percorso di studi in sé e i risultati attenuti da chi si diploma con una licenza classica. Il fatto che chi esce dal liceo classico si dimostri, come più volte affermato da Vecchioni, ‘più bravo’ degli altri può derivare da tanti altri fattori. Uno di questi è che chi sceglie di frequentarlo ha spesso alle spalle un ambiente culturalmente florido, venendo da una famiglia che già condivide una certa visione educativa. Per tali ragioni la loro formazione inizia già dall’infanzia e non è ascrivibile unicamente agli anni del liceo, partendo già in una posizione di vantaggio”
Poi continua: “Una riflessione differente la merita invece l’indirizzo di studi del liceo classico. Questo infatti è l’unico liceo in cui si studiano altre due culture oltre quella italiana, tra l’altro radicalmente diverse dalla nostra. Se presentate bene queste costituiscono davvero un grande arricchimento, facendo sì che il ragazzo scopra come il mondo si possa pensare in un modo radicalmente diverso da come lo immaginiamo. Lo fa attraverso i grandi testi, offrendo importanti esperienze culturali lontane da noi”. Conseguentemente tiene a specificare: “Ovviamente a un patto, ovvero quello per cui le cose si facciano bene. Se si fa il liceo classico semplicemente per insegnare la sintassi del latino e del greco allora non serve a niente, si finisce per studiare solo una lingua altra. Se, invece, anche la lingua si affronta come un’alterità culturale, allora, può valere davvero la pena frequentare il classico”.
La peculiarità di quest’ultimo, dunque, starebbe proprio nell’offrire una pluralità di punti di vista assai distanti da quello che la nostra società condivide. Come Bettini spiega, infatti: “Viviamo in una cultura cristiana o post-cristiana, ovvero che condivide un orizzonte religioso ispirato al cristianesimo oppure uno in cui questo è presente solo residualmente. Col classico si ha l’opportunità di studiare due culture in cui esistevano due religioni completamente differenti e ovviamente ciò è una grande esperienza che si offre ai ragazzi. Di nuovo, però, a patto che gliela si faccia fare”. Lo studio delle lingue, da solo, però non basta e c’è bisogno che le potenzialità del classico vengano messe a frutto: “In conclusione credo che il liceo classico abbia grandissime opportunità, il programma di studio è molto solido e impegnativo, l’importante è che le due lingue classiche siano per l’appunto lingue e culture classiche, e che queste vengano insegnate da professori che non insegnino solo la grammatica ma siano appassionati di tali culture”.
Gli chiedo se il classico abbia una marcia in più, come spesso si sente dire, o se le sue siano solo peculiarità come quelle che possiede qualunque altro percorso di studi. Una domanda che mette radici nei miei anni liceali, quando frequentavo un liceo che ospitava l’indirizzo di studi classico, quello linguistico o lo scientifico opzione scienze applicate. Da studente di quest’ultimo, infatti, la costante che accomunava me e i miei compagni era quella di sentirci un po’ figli di un dio minore. A foraggiare ciò, purtroppo, spesso erano proprio i professori stessi.
“Non è che chi ha frequentato il classico sia un uomo o una donna colta, non è questo il punto. Chi lo ha fatto va concepito solo come qualcuno che ha avuto delle opportunità culturali che altri non hanno avuto. Per esempio quella di sapere che effettivamente la nostra lingua derivi dal latino e in parte dal greco. Per tale ragione ha inevitabilmente una conoscenza dell’italiano che altri non hanno. Inoltre, l’aver studiato il mondo antico fa vedere le origini di tanta arte che da esso trae spunto, ma soprattutto fa sì che si possano vistare i tanti musei che abbiamo con occhi differenti. Un ragazzo italiano che ha avuto la fortuna di studiare al classico inevitabilmente visita il Museo Archeologico di Napoli con un altro sguardo, sapendo cosa viene rappresentato. A riguardo è inutile negarlo, l’Italia è un paese ricchissimo di passato classico e ignorarlo sarebbe davvero un peccato”. Detto ciò, tiene a precisare: “Dunque, lungi dal voler fare un’apologia del passato classico, ne farei più che altro una della conoscenza del mondo antico. Ben verrebbe per me aggiungere elementi di conoscenza della classicità dentro altri indirizzi di studio superiori, e perché no anche inferiori, dato che viviamo in un paese un po’ diverso da tutti gli altri carico di classicità”.
A questo punto chiedo a Bettini se le spoglie elitarie che alle volte contraddistinguono il liceo classico, figlie di una concezione di gentiliana memoria che perdura ancora oggi, non minino in primo luogo lo stesso indirizzo di studi. “Ciò fa assolutamente del male al liceo classico, mantenendo viva quest’aura di aristocrazia che lo connota assolutamente infondata – afferma, sottolineando subito dopo – indipendentemente che sia classica, scientifica o altro, la scuola superiore deve essere un’occasione per il ragazzo di farsi comunque una cultura, di maturare una mentalità critica e non solo un mezzo per studiare le discipline che gli serviranno nell’immediato. Su questo punto do ragione a Vecchioni. Nella vita ci sono stagioni e stagioni, e quella che va da 14 ai 18 anni deve essere una stagione libera, in cui il ragazzo si apre al mondo e ne capisce il funzionamento. A maneggiare circuiti elettronici imparerà dopo, per acquisire le competenze tecniche c’è tempo, le superiori sono invece il momento della formazione. Interpretarle come un momento di preparazione a ciò che servirà, accusando il greco e il latino di non servire a nulla, è una conseguenza della società neocapitalista in cui siamo immersi. Le scuole superiori, questo è un punto che mi preme molto, dovrebbero dunque essere delle scuole di formazione e non di preparazione, cosa che sembra stiano sempre più diventando. Non si viene al mondo solo per produrre”.
In ultima battuta, alla luce delle innumerevoli proposte di riforma che negli anni hanno contraddistinto il classico, gli chiedo una sua opinione in merito: “Non starei sempre a riformare la scuola altrimenti gli insegnanti non ci capiscono più niente. Cercherei solo di sfruttare meglio quanto si fa e le direttive ministeriali, che sono molto aperte anche se in molti sembrano non riconoscerlo. Non esiste più un programma da seguire, esistono delle indicazioni che ognuno articola secondo la propria sensibilità didattica. C’è bisogno che la scuola e le famiglie si rendano conto che si può articolare il processo formativo con una certa libertà”.