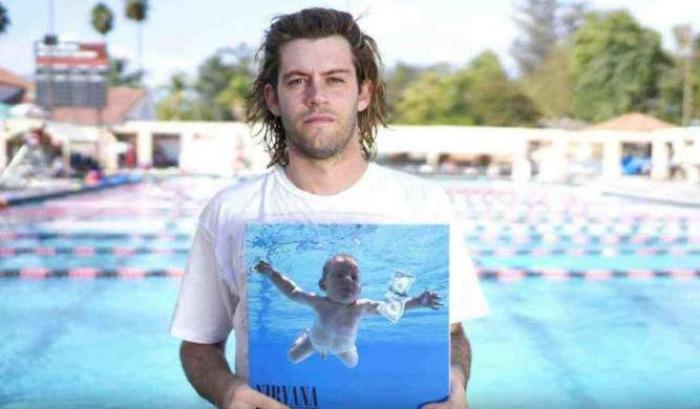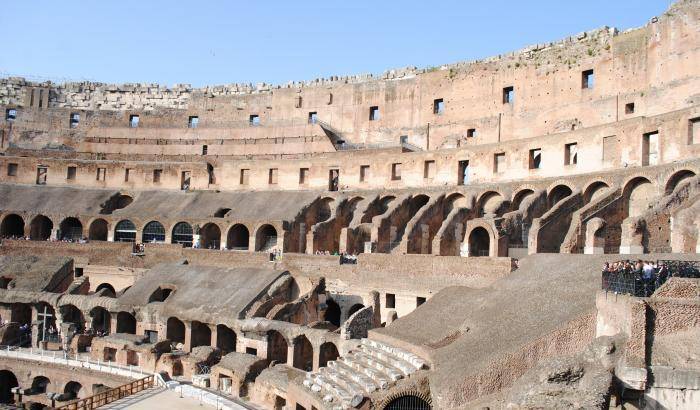La violenza di genere, un tempo relegata alla sola sfera fisica o privata, ha trovato un nuovo e pervasivo campo di azione: lo spazio digitale, con ripercussioni dirette e devastanti anche nel contesto lavorativo. Questo fenomeno non è più un problema personale, ma una criticità che ostacola la crescita professionale delle donne – attraverso l’autocensura, la limitazione della presenza online e, nei casi estremi, l’abbandono del posto di lavoro – e danneggia l’intera organizzazione, minando coesione interna e reputazione.
È in questo scenario che Valore D, in collaborazione con PermessoNegato e Fondazione Una Nessuna Centomila, ha presentato la seconda fase della sua policy “Dal silenzio all’azione“, un vero e proprio piano di intervento mirato al mondo aziendale. Il messaggio è chiaro: per contrastare efficacemente la violenza di genere digitale sul luogo di lavoro, sono necessarie azioni concrete, strategiche e integrate in tutti i processi aziendali, abbandonando le iniziative sporadiche e le semplici campagne di comunicazione.
La necessità di un approccio strutturato è urgente, come dimostra l’ultima indagine dell’OsservatorioD (realizzato da SWG per Valore D). Sebbene la consapevolezza generale sul tema sia diffusa – quasi il 75% degli italiani conosce fenomeni come cyberbullismo e revenge porn – la conoscenza crolla drasticamente quando si affrontano forme meno note ma ugualmente dannose, come la sextortion (estorsione basata su immagini intime) o il doxing (diffusione di dati privati e sensibili): solo 4 italiani su 10 ne sono a conoscenza. Eppure, il 64% della popolazione intervistata riconosce che questa violenza può manifestarsi anche in ambito professionale.
Come ha spiegato la direttrice generale di Valore D, Barbara Falcomer, l’obiettivo è offrire alle aziende un modello di riferimento per creare ambienti digitali sicuri, contrastare le discriminazioni e sostenere chi subisce abusi. Nicole Monte, vicepresidente di Permesso Negato, ha aggiunto che l’investimento cruciale è sul consenso digitale, spesso “il grande assente nella cultura online contemporanea”, ribadendo che identità e immagini digitali sono proprietà inalienabile dell’individuo.
Il fenomeno colpisce con particolare intensità le nuove generazioni: il 15% dei giovani tra i 18 e i 34 anni ha dichiarato di aver subito personalmente episodi di violenza digitale. Oltre l’80% degli intervistati considera il problema grave, legandolo a effetti concreti sulla salute mentale e, per il 78%, a una chiara mancanza di educazione digitale ed emotiva. Non a caso, giovani e donne, in particolare, individuano la matrice del problema nella cultura patriarcale (63%).
Per rispondere a questa complessità, il piano d’azione proposto fornisce indicazioni precise: si va dalla mappatura dei rischi digitali all’introduzione di codici etici e di condotta aggiornati, fino alla definizione di protocolli per la gestione delle crisi reputazionali che possono nascere da abusi online. Fondamentale è l’impegno sul fronte del supporto alle vittime: le aziende sono invitate a garantire canali di segnalazione anonimi, assistenza psicologica e legale, e a coltivare una cultura aziendale che condanni qualsiasi forma di colpevolizzazione della vittima.